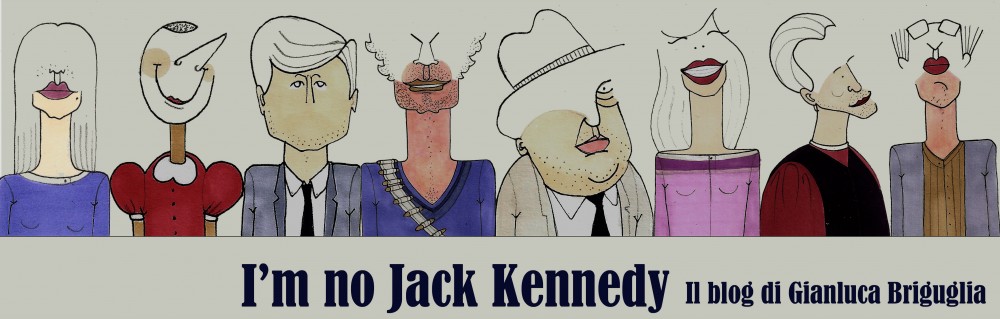Non voglio fare polemica e probabilmente mi esprimo rozzamente, ma di alcune delle tesi di Orsini (non tutte) che all’inizio della guerra suonavano quasi scandalose ma ponevano degli interrogativi interessanti, a distanza di più di un mese dall’inizio della guerra si può dire che suonino per certi aspetti anche errate. Certo la guerra non è finita e non sappiamo come finirà, ma è ormai innegabile che Putin avesse sbagliato i conti.
E suonano errate quelle tesi – almeno a me che non sono un tecnico – perché Orsini nelle varie trasmissioni televisive aveva fatto un semplice calcolo aritmetico, cioè: siccome la Russia è molto più forte dell’Ucraina, la Russia può militarmente fare quello che vuole con l’Ucraina. Lui diceva e dice “sventra l’Ucraina quando vuole”.
Quindi, era la conclusione “scandalosa”, l’Ucraina si deve arrendere immediatamente (eravamo al secondo o terzo giorno di guerra, quando era già chiaro che Putin volesse impossessarsi di tutto il territorio e cambiare governo e costituzione) e noi dobbiamo spingerla ad arrendersi. In sostanza, la sua analisi non prendeva in considerazione nessun elemento e scenario politico, economico, diplomatico alternativo al suo calcolo aritmetico al giorno uno.
Adesso Orsini ha sfumato la sua posizione, perché specifica che la Russia ha un obiettivo minimo e uno massimo (prima diceva che l’Ucraina ha già perso) – e quindi però se l’Ucraina si fosse arresa nella prima settimana che cosa avrebbe ottenuto la Russia? Il minimo o il massimo? Le due cose non si equivalgono. Non è forse il passare a un obiettivo minimo uno dei risultati della resistenza ucraina? Orsini dice ora, non lo diceva mi pare all’inizio, che la sua analisi è però valida ceteris paribus, cioè a fissità di tutte le altre condizioni, cioè dei rapporti di forza iniziali, compresi quelli politici, economici etc. Ma è proprio su tutte queste condizioni che ucraini, europei e occidentali hanno lavorato e stanno lavorando (per carità, forse anche sbagliando alcuni strumenti e scartandone di alternativi).
In questo mese il sostegno compatto all’Ucraina, con anche le famose armi (ma, almeno per il momento, con armi che non portano all’escalation internazionale), il contrattacco economico e finanziario alla Russia da parte di UE e paesi occidentali, ha determinato uno scenario che ha reso molto più debole Putin dal punto di vista politico esterno e interno. Ed è proprio questo che sta creando le condizioni per una trattativa e per un ridimensionamento delle pretese sull’Ucraina.
Se anche oggi la Russia dovesse vincere e invadere tutto il territorio ucraino, la sua posizione non sarebbe forte come al momento iniziale. Non solo è divenuto chiaro che la conquista del territorio non concluderebbe il conflitto che doveva durare 48 ore (e che invece con la resa immediata sarebbe stato chiuso subito con il rafforzamento della Russia e con il crescere delle sue pretese anche su altri territori), ma è forse vero che una parte dello stesso establishment russo è ormai dubbioso sulla bontà della politica putiniana (cosa che non era due mesi fa) ed è chiaro che la società russa ha manifestato, in questo lasso di tempo, preoccupazioni e dissensi a vari livelli che rafforzano le possibilità di un cambio di rotta.
In sostanza: in tempi di guerra, la resistenza e l’azione militare sono anche strumenti diplomatici, non sono opposizione cieca e disperata a uno stato di fatto militare, che in questo caso specifico hanno contribuito grandemente a cambiare alcuni dati fattuali fondamentali. Tutto questo è avvenuto proprio perchè l’Ucraina non si è arresa dopo 48 ore.
Certo, è vero che Putin può distruggere Varsavia in 30 secondi e può “sventrare” quasi qualsiasi paese vicino, ma le altre condizioni (il “rimanendo ferme le altre cose”, il “ceteris paribus” di cui parla Orsini solo per non prenderlo in considerazione) non solo sono cambiate, ma sono tutta l’enorme partita politica che si sta giocando. Per questo mi pare che quello che Orsini diceva un mese fa (e che piano piano egli stesso sta rendendo più complesso) prima sembrava scandaloso, adesso semplicemente, in buona parte, errato.